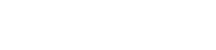CRITICA: RIFLESSIONI SULL’IO DELLA POESIA
C’è una lunga e ormai quasi fastidiosa diatriba, oggi, in Italia, sul soggettivismo pletorico della nuova poesia italiana. Io lo direi piuttosto un’espansione patologica dell’ego. Giustamente alcuni poeti cercano di districarsi dall’imbroglio “lirico”. Altri attaccano, e con buone ragioni, l’ipertrofia di uno sguardo fissato costantemente sul proprio ombelico. Ma senza tuttavia contrapporre una reale uscita dal predominio quasi esclusivamente autobiografico di un io onnivoro. Il punto è che uscire dall’intrico non sta nel liberarsi dello sguardo puntato su sé stessi o che guarda al mondo come una proiezione delle proprie emozioni, bensì nel rendere oggettivo il soggetto, narrativo o addirittura esteriore, quasi separato dallo scrivente, l’io interno, e nel modellare la lingua non come la lingua di un diario intimo, l’appunto di una confessione privata, bensì come la lingua di un referto, di una registrazione di stato, mentale o aneddotico che sia, la lingua privata del sostegno d’approvazione autobiografico – lo sento e dunque è vero – ma una lingua che rappresenti qualcosa che accade e può accadere a chiunque. La funzione delle avanguardie storiche fu proprio di liberare la lingua poetica dalla zavorra del soggettivismo lirico, rifondare il linguaggio come materia comune e aperta a qualunque sperimentazione, perfino alla privazione di senso, privato di senso come era ormai il senso della confessione intima. Ma non si può procedere in eterno decostruendo le macerie di ciò ch’era stato l’io poetizzante di otto secoli. E qui va fatta una precisazione. L’io di Bernard de Ventadorn, di Arnaut Daniel, di Cavalcanti, di Dante e perfino di Petrarca non ha niente a condividere con l’io fagocitante di troppa poesia italiana del Novecento. È un io oggettivato, da non confondersi con l’io biografico del poeta. Nella Commedia Dante è sia il narratore che il personaggio del poema. Che siano la stessa persona è una finzione dell’io narrante, sul quale fatto Dante fonda la verità del messaggio. Ma quella stessa verità è una verità poetica da non confondere, come lui stesso afferma nella lettera a Can Grande della Scala con la verità della Rivelazione, la verità teologica. Anche se poi il poeta gioca a mescolare le carte, come nei canti del Paradiso dove il pellegrino Dante è interrogato sulle tre virtù teologali. Alla giustezza delle risposte, e dunque al superamento dell’esame, i beati esultano e tutto il cielo s’illumina, anzi si accende come un fuoco, in quel grido di esultanza. Ma subito San Pietro riconduce il discorso al destino terreno della Chiesa pronunciando parole di condanna le più gravi di tutto il poema:
Quelli ch’usurpa in terra il luogo mio,
il luogo mio, il luogo mio, che vaca
ne la presenza del Figliuol di Dio,
fatt’ha del cimitero mio cloaca
del sangue e de la puzza; onde ‘l perverso
che cadde di qua sù, là giù si placa.
Paradiso, XVII, 22-27
Dunque affermare che con Dante abbia principio il prevalere del’io biografico nella poesia italiana, è un madornale errore d’incomprensione, perché quell’io è una finzione poetica, per di più regolata dalle teorie retoriche del tempo. Il viaggio ultramondano di Dante è un exemplum modellato su una lunga tradizione di speculazione mistica, sia cristiana, sia perfino islamica, come ha dimostrato Miguel Asín Palacios(1). Se mai il principio di un esasperato soggettivismo lirico potrebbe riconoscersi nella poesia di Petrarca, ma anche qui ci si troverebbe fuori strada, perché anche l’io di Petrarca è un io tutt’altro che biografico, soggettivo, ma anzi che si pone anch’esso come exemplum, modello di comportamento umano, e anch’esso inserito nella storia universale della redenzione cristiana: tant’è vero che le Rerum vulgarium fragmenta, il Canzoniere, come verrà chiamato poi, si conclude con una canzone alla Vergine, nella quale il linguaggio amoroso si converte in esperienza religiosa. Conversione già accennata da Dante, alla fine del suo poema, relegando alla voce di San Bernardo l’intercessione alla Madonna perché il pellegrino acceda all’ultima visione di Dio. E San Bernardo è il mistico che ha riutilizzato il vocabolario dei trovatori per celebrare non più la Donna del proprio segreto amore, ma la Donna resa incinta dall’“Amor che muove il sole e l’altre stelle” per redimere l’uomo dal peccato originale, la Donna ch’è il modello più alto dell’essere donna, Maria, la “figlia del suo figlio”, la madre di Dio. Su questa linea si arriva all’“ewig-weibliche”, l’eterno femminino, che chiude il poema drammatico di Faust. Ma scendiamo da queste troppo alte sfere. O cerchiamole per altre vie.
Ecco qui gli esempi di tre bellissime poesie di due grandi poeti, che anch’essi, apparentemente, sembrano parlare solo di sé stessi. Sono quasi contemporanei. Uno è Guido Cavalcanti, 1255-1300. L’altro è Ḥāfeẓ, poeta persiano del XIV secolo (1315-1390), ammirato da Goethe. Leggiamo tre delle loro poesie, una di Cavalcanti e due di Ḥāfeẓ.
Cavalcanti:
Tu m’hai sì piena di dolor la mente,
che l’anima si briga di partire,
e li sospir’ che manda ‘l cor dolente
mostrano agli occhi che non può soffrire.
Amor, che lo tuo grande valor sente,
dice: «E’ mi duol che ti convien morire
per questa fiera donna, che nïente
par che piatate di te voglia udire».
I’ vo come colui ch’è fuor di vita,
che pare, a chi lo sguarda, ch’omo sia
fatto di rame o di pietra o di legno,
che si conduca sol per maestria
e porti ne lo core una ferita
che sia, com’ egli è morto, aperto segno.
Ed ecco Ḥāfeẓ:
1.
Veramente infinita è la bruna dolcezza d’un corpo,
e il bruno vino dell’occhio, e il riso del labbro, e la grande letizia del volto!
Io sono lo schiavo di tutte le bocche soavi del mondo,
ma questo è un sovrano che tutte le bocche soavi suggella.
Questa gota colore del grano maturo c’insegna
perchè, come Adamo si volse alla spiga, si perse.
In nome di Dio, dite, amici, per questa ferita
quale balsamo resta sul cuore, se egli è partito?
Bello il volto, è perfetta virtù, ed è limpido il grembo:
a lui gli angeli e i puri del mondo s’affannano attorno.
Chi potrà credermi dunque se è lui che petroso m’uccide,
e pur lui che qual Cristo richiama con soffio lievissimo a vita?
Io sono un poeta che crede: si tenga di me qualche conto,
perché ben conosco la grazia, conosco il perdono dei santi (2).
2.
È stupore in germoglio che cresce, l’amore per te:
ogni volta che prossimi siamo è compiuto stupore.
Nell’incontro con te s’immergevano immemori in molti,
ma non altro, ecco, l’esito fu che un immenso stupore.
Nulla resta, né noi, né lo starcene accanto fra noi,
ogni volta che giunge fantasticheria di stupore.
C’è mai forse un amante, in ricerca di te sulla via,
cui non sia il volto adorno da un neo di stupore?
Io, dovunque tendessi l’orecchio,sentivo soltanto
domande che erano dettate da incerto stupore.
Non è in tutto l’essere suo che stupore, il poeta:
un germoglio d’attonito affetto, sì, un lussureggiante stupore(3).
Non è qui il luogo per commentare stile e senso delle poesie, ma sì per leggere in che senso l’io poetante è assunto. Del poeta persiano ne sono state scelte due, perché poeta poco familiare al lettore italiano e di una cultura di cui in genere in Italia il lettore medio non sa nulla. Due poesie, pertanto, possono introdurre meglio il lettore nella costruzione del suo linguaggio poetico, pur tenendo presente che si tratta di traduzioni e non degli originali in lingua farsi. La musica del verso pertanto è perduta.
Ma anche a una lettura distratta e frettolosa salterà evidente al lettore che l’io poetante non racconta la propria immediata esperienza, bensì la filtra attraverso i modelli di una tradizione poetica che ha regolato la descrizione della vita, e in particolare della propria, ubbidendo a un codice di pensiero e di sistemi figurativi oggettivi, non individuali, ma comuni. Le prime due quartine dello stupendo sonetto di Cavalcanti possono far pensare a una confessione intima. “Tu m’hai sì piena di dolor la mente”, ma subito il poeta devia il discorso verso una descrizione oggettiva di quanto gli accade, secondo gli schemi della psicologia scolastica. Si pensa perfino a una poesia famosa di Saffo, che certamente Cavalcanti non conosceva: φαίνεται μοι ..., nella quale la sofferenza è raccontata con gli effetti fisici che produce nel corpo. Ma le terzine chiariscono la situazione: l’amore lo ha reso un automa, un corpo morto, qualcuno che cammina solo “per maestria”. L’amore uccide, oggi diremmo, uccide la propria individualità, la propria libertà. Cavalcanti è più oggettivo: l’amore gli toglie la vita, lo fa apparire vivo, ma come un automa. È una visione disperata, lontana dalla speranza salvifica della teorizzazione di Dante. Non c’è una trascendenza, c’è il qui della vita ch’è tolta e che consegna l’amante alla morte. Non a caso Dante, quando nel X canto dell’Inferno incontra il padre di Cavalcanti, lo immagina destinato ala stessa tomba infuocata di chi non crede alla sopravvivenza dopo la morte. Cavalcanti sembra confessarlo: “l’anima si briga di partire”. Bisogna arrivare a Leopardi per incontrare un poeta che parlando di sé stesso esprima lo stesso carattere di constatazione di una realtà oggettiva, di una condanna che consiste già nel semplice fatto di esistere.
Tutt’altro mondo è quello del poeta persiano Ḥāfeẓ. Ma come Cavalcanti non ha nessuna intenzione di raccontarci la sua individuale pena d’amore, bensì attraverso il racconto della pena di rappresentare una condizione perenne dell’animo di chiunque. Ḥāfeẓ, però, a differenza di Cavalcanti, è un poeta profondamente religioso, anzi addirittura mistico, e aderisce al misticismo sufi. In questo ha qualche affinità con Dante. Ma non sarebbe un poeta persiano se non affondasse in un panorama linguistico di metafore e di immagini che significano infinite cose, dall’immediata sensualità erotica, perfino omoerotica – ed è un musulmano! – se il dato concreto della sensualità fisica non alludesse all’estasi di altri rapimenti, la congiunzione carnale non ricordasse congiunzioni con il divino, l’ebbrezza provocata dal vino non esprimesse l’ebbrezza di estasi extratemporali, ultramondane. “Infinita è la bruna dolcezza di un corpo”, ma si può dire meglio l’ampiezza, la vastità non solo di sensazioni, ma di senso della vita e di ciò che va oltre la vita, scatenata dalla voluttà di un corpo? E si può definire meglio la poesia che assimilandola allo stupore di un amore, un “lussureggiante stupore”, sembra cogliere la natura stessa della poesia?
Altre riflessioni il lettore può trarle da sé. Ma tali riflessioni lo condurranno a toccare con evidenza ciò che manca a quasi tutta la poesia italiana di oggi: lo stupore, appunto, di raccontare un mondo, invece di chiudersi nella consolante contemplazione del proprio ombelico. E non perché, come da secoli, da millenni, il poeta dice: “io”. Ma perché l’io del sedicente poeta italiano attuale è l’io piccolo (verrebbe voglia di dire “piccoloborghese”), biografico, che sa vedere solo sé stesso, e fosse, ma nemmeno in sé stesso riesce a trovare una verità che sia di tutti. Crede, anzi, che l’unica cosa che conti sia comunicare le proprie emozioni. E non sa che il poeta non comunica mai le proprio emozioni, ma solo la verità delle proprie emozioni, ch’è tutt’altra cosa. Vale a dire che deve conoscerle, non basta provarle, deve conoscerle per raccontarle. Perché ciò che lo accomuna agli altri non sono le emozioni, ma la consapevolezza di che cosa sono le sue emozioni, di che cosa significano le emozioni che prova, che pensiero dell’uomo, e della realtà, si cela in esse e, soprattutto, conosce il modo giusto, vero, di dirle. Una poesia che non sia anche pensiero – non mi si fraintenda: non già ragionamento, non certo logica, ma pensiero, riflessione, consapevolezza, come c’è un pensiero musicale, un pensiero pittorico, architettonico, e così via – una poesia che non sia, prima di tutto, invenzione di un linguaggio, una poesia che si limiti allo sfogatoio di lagne quotidiane o manifesto di slogan, di concetti banali sulla vita, non è poesia. La poesia è l’ebbrezza, l’estasi di un io che si trascende e che si fa non già un io impersonale, ma l’io personale di tutti e di tutte le cose, perché ha trovato la lingua giusta per dirlo.
Tuttavia, ci si potrebbe chiedere che spazio occupi in tutto questo la poesia di tradizione orale, che come si sa, è nata e si è sviluppata in tutte le civiltà della terra. Gli stessi, geniali, poemi omerici sono preceduti da una lunga tradizione di recitazione “improvvisata” di racconti mitici o di gesta familiari. Come pure lechansons de geste francesi nascono da tradizioni orali che trovano poi il poeta che dà loro veste scritta. Nino Pirrotta, il grande musicologo italiano, scrive della musica medievale ci è arrivata solo quella scritta nelle cappelle delle cattedrali e nei monasteri o registrata su manoscritti da intellettuali del tempo. Ma il più della musica che si faceva, canti, danze, nelle campagne, nei castelli, non era scritta, si tramandava di generazione in generazione di cantori. Avremmo dunque un’idea sbagliata della produzione musicale e poetica del medioevo se ci riferissimo solo alla musica e alla poesia che ci sono arrivate scritte. E, si badi, l’improvvisazione della tradizione orale non è improvvisazione di qualcosa che prima non c’era, non è attuata dal niente, ma segue una lunga tradizione di regole e di formule. Formule, ed espressioni formulari, che per esempio riconosciamo nei poemi di Omero. Dunque anche la tradizione orale conosce regole, si basa sulla consapevolezza degli strumenti linguistici che si mettono in moto, e non sono, queste poesie, questi poemi, l’ingenua improvvisazione dal niente di abili cantori e cantastorie. In altre parole, qualunque poesia, che sia davvero tale, non nasce da un impulso immediato e inconsapevole, ma è frutto di una elaborata tradizione e di una consapevole rielaborazione di questa tradizione. Che poi il singolo cantore, il singolo poeta, possa pensare di trarre dal niente la sua ispirazione è solo un inganno psicologico, perché di fatto vuol dire, invece, che la tradizione dentro la quale è nato egli l’ha introiettata, l’ha assunta come propria, anzi quasi come una necessità di natura. Nessuno nasce imparato, dice un proverbio.
Per concludere questi appunti sulla natura dell’io poetante e dunque della poesia, ritorniamo in Persia. Leggiamo una poesia della grande poetessa iraniana Forugh Farrokhzad (1934-1967). È una poesia di esasperato intimismo. L’io impone la propria esperienza ad ogni parola. Ma la lezione di Saffo è stata appresa. È un io che per apparire s’incanala nella lingua di una poesia antica di secoli, oggettiva il proprio dolore in un ventaglio d’immagini che fanno parte anche della lingua per dirle, e della tradizione religiosa (come per Saffo) della propria cultura. Non è lo sfogo di un disagio, ma la rappresentazione, quasi rituale, di una condizione umana, i cui risvolti ci coinvolgono, ci appartengono, perché ad ognuno di noi quelle parole non solo parlano, ma parlandoci ci dicono ciò che noi stessi potremmo dire di noi. “Non credere che il mio cuore / sia amico intimo della mia lingua”: si può dire meglio la distanza, il mistero che si attua tra il sentimento che si prova e la parola che lo dice? e meglio, appunto, così, la natura della poesia? Le Muse dicono a Esiodo di saper dire molte menzogne che sembrano verità, ma anche molte verità che sembrano menzogne. Dentro questa inafferrabile ambiguità sta il segreto della poesia. E allora sì, come dice Farugh: “un’estasi si nasconde nelle tue parole”, nelle parole, nella poesia.
CONFESSIONE
Perché io ti nasconda di nuovo
il segreto di questa mente turbata,
lascio cadere delicatamente
il velo scuro delle ciglia.
Il cuore è in preda a una voglia che brucia l’anima,
in Dio cerco la via che mi salvi.
Devotamente ti parlo adesso
della pietà e del pentimento.
Ah ... noncredere che il mio cuore
sia amico intimo della mia lingua,
bugie, erano bugie tutto ciò che dissi,
ti ho forse mai detto quello che il cuore ama sentire?
Intoni un canto per me,
un’estasi si nasconde nelle tue parole,
forse il mio sonno e il tuo canto
sono il segno di un mondo d’altrove(4).
DINO VILLATICO
1 Miguel Asín Palacios, Dante y el Islam, la escatología musulmana en la Divina Comedia, 1919.
2 In https://alessandrocanzian.com/2014/01/05/ben-sapeva-che-il-cuore-hafez/
3 In Ḥāfeẓ, Ottanta canzoni, Torino, Einaudi, 2008.
4 In Forugh Farrokhzad, io parlo dai confini della notte, tutte le poesie, Milano, Bompiani Capoversi, 2023.