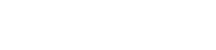LETTERE: IL MIO PASSATO È UN FIUME MALVAGIO
«A proposito, il modo migliore per evitare
i serpenti velenosi è ucciderli a vista
per non calpestare lo stesso serpente tre metri più in là.»
WILLIAM S. BURROUGHS (1914-1997)
Rifuggo sempre dagli epistolari, noiose e false raccolte di lettere scritte ben consapevoli della loro pubblicazione; ma con William S. Burroughs ero sicuro di evitarmi almeno la falsità, e non ho sbagliato, nonostante a un certo punto scriva: “Farò bene a conservare le mie lettere, magari riusciranno a ricavarci un libro quando mi sarò fatto un nome.” (p. 52).
Però, purtroppo neanche Burroughs ci risparmia la noia, perché non vi è nulla di più noioso di leggere le lettere di un tossico e omosessuale affetto da satiriasi che, da mattina a sera, scrive di come si danna la vita per escogitare il modo di procurarsi la roba, il modo e i soldi per comprarla e produrla, e come fare per abbordare giovani ragazzi, sbandati o poveri, ai limiti della pedofilia (“[...] ci ho provato con un tredicenne indio in faccia al padre, ai fratelli e agli zii, mi sono portato a casa due straccioncelli.” p. 70), ovunque si trovi: “Ti ho mai detto di quando io e Marv abbiamo dato sessanta centesimi a due ragazzini arabi per guardarli scoparsi l’un l’altro? – esigendo tanto di sperma, non un’inculata a metà. Chiedo a Marv: ‘Secondo te lo fanno?’ e lui dice: ‘Secondo me sì. Hanno fame’. L’hanno fatto.” (p. 129). E il tutto del detto e ridetto in questo libro si esaurisce già nelle prime 70-80 pagine.
Intanto in queste lettere emerge un Burroughs di estrema destra, ai confini con il fascismo; anzi no, fascista proprio appare Burroughs in queste sue lettere, ché ha in odio ogni forma di assistenzialismo a partire dal New Deal, vale a dire le riforme economiche e sociali promosse Franklin Delano Roosevelt nel decennio 1933-1943 che risollevarono gli Stati Uniti d’America dalla grave crisi del ‘29, dispositivo legislativo che Burroughs riteneva essere il cavallo di Troia del socialismo e del comunismo, che più di ogni altra cosa detestava, che, a suo dire, avrebbe fatto diventare in breve tempo l’intero Paese come l’Unione Sovietica – come non si può non rilevare l’indifferente odio nutrito verso i democratici: in tutta l’epistole non si trova una sola parola scritta in merito all’assassino di John Fitzgerald Kennedy, Dallas, 22 novembre 1963, fatto che ha segnato una intera epoca. Insomma, Burroughs era un figlio di papà che odiava i poveri, però, buoni da sfruttare per il raccolto: “[...] hanno espulso i nostri braccianti [...] E se un manipolo osceno di burocrati è convinto che ce ne staremo a grattarci il culo [...] si accorgeranno che non siamo liberal.” scrive furioso per gli esiti di un controllo sulle sue coltivazioni del Dipartimento dell’Agricoltura in una lettera da Pharr, Texas, del 24 giugno 1949 indirizzata a Jack Kerouac (pp. 24-25) – di particolare interesse sul tema è anche la lunga lettera ad Allen Ginsberg del 1° maggio 1950 (pp. 30-35) dove reclama le migliori condizioni di lavoro che erano offerte all’immigrato clandestino messicano rispetto a quelle di cui godeva in patria; omettendo però che erano assai meno vantaggiose delle condizioni di lavoro medie offerte a un lavoratore regolare statunitense in pieno boom economico che con il proprio impiego poteva permettersi: casa unifamiliare di proprietà con tutti i confort del periodo, due automobili di grossa cilindrata in garage con motorizzazione a benzina e assicurazione sanitaria per tutta la famiglia. In altre parole, Burroughs in questa sua lettera, senza rendersene conto perché da buon capitalista fascista era solo al proprio profitto che pensava, tentava una impossibile giustificazione al caporalato affermando che, in ogni modo, questi immigrati clandestini stavano sicuramente meglio a spaccarsi la schiena padre madre e figli sulle piantagioni del Texas che a restarsene in Messico, fino ad arrivare a pensare di spostare tutti i suoi investimenti oltre confine per non dover più rispondere a obblighi legislativi che, a suo dire, compromettevano i suoi privatissimi interessi economici, che gli erano necessari soprattutto per comprare le droghe più svariate e per buttare luride mance ai regazzini, mentre negli U.S.A. già si discuteva di salario minimo (ma su questa lettera tornerò in seguito perché, a margine, offre un altro tema di stretta attualità, quello su società & omosessualità), in buona sostanza praticando una delocalizzazione prima della lettera. Una idea e un sentimento anche di società erano i suoi molto vicini al sentire politico dell’attuale destra europea di ispirazione fascista, con la quale condivideva pure il principio di legittima difesa della persona e della proprietà privata e la giusta detenzione delle armi utili a esercitarlo, fino a sfociare nel negazionismo revisionista: “A volte penso che la storia del Partito Comunista e della Russia sia stata tutta una trovata dei reazionari per screditare in eterno la sinistra. Be’, la politica non mi interessa molto, anche se un bel movimento bombarolo vecchio stile mi divertirebbe.” (p. 61). Molto attuale anche la sua visione dell’Islam: “Maometto? Vuoi scherzare? È un’invenzione della Camera di Commercio della Mecca. Il copione l’ha scritto un pubblicitario egiziano rovinato dall’alcol...” (p. 150). E sempre da Tangeri, in una lettera datata 29 ottobre 1956 indirizzata ancora a Ginsberg, scrisse: “Questa città ha il panico da jihad – il jihad è lo sterminio dei miscredenti da parte dei mussulmani.” (p. 153); e più avanti, nella stessa lettera: “Che bel modo di suicidarsi, farsi ridurre a brandelli dagli arabi.” (p. 158). E di certa destra ricorda anche certe inclinazioni mafiose: “L’idea di fondo è che i don mafiosi siano governanti più buoni assennati e giusti [...]” e quell’odio sadico per la protesta: “Ho una TV a colori ed è il massimo per guardare le immagini di Belfast che sono soprattutto incendi, lanci di pietre e proiettili di gomma a volontà. È come la guerra in Algeria. Ammazzano vecchie e bambini. Ammazzano o storpiano chiunque sia lì al momento sbagliato.” (p. 293)
Ecco, questa scoperta già salva il libro e rende sopportabile la noia di leggere lo scrivere lettere di un tossico brutto e pericoloso (molti lo tennero a debita distanza per evitare guai con la polizia ovunque si trovasse, tra i quali Paul Bowles, Tennessee Williams e Truman Capote a Tangeri, in Marocco: “Ma a quanto pare hanno fiutato la mia diversità e mi hanno escluso, proprio come fanno d’istinto tutti i tipi banali.” p. 107) preso dalla scimmia che stravedeva a Città del Messico il Paradiso in terra perché: “Tutte le forze dell’ordine sono corruttibili [...]” (p. 29) ma in realtà stava solo scappando dalle prigioni statunitensi e, presto, sarebbe fuggito anche da quelle messicane.
C’è poi un vuoto di quasi un anno nell’epistole, cioè dal maggio 1951 all’aprile 1952, e le due lettere che confinano questo silenzio sono entrambe indirizzate a Kerouac (pp. 42, 45). Il 6 settembre 1951 Burroughs uccise accidentalmente la moglie Joan Vollmer, di anni 28. Nel tardo pomeriggio nel loro piccolo appartamento dove facevano bisboccia insieme a due amici, i coniugi decisero di mostrare ai due quanto Burroughs fosse bravo con la pistola. Allora Joan si mise seduta e di fianco a circa due metri di distanza dal marito. Poi riempi un bicchiere di cognac, lo mise in equilibrio sulla testa e Burroughs sparò ma invece del bicchiere prese la moglie alla tempia uccidendola dentro una agonia di poche ore. Ovviamente, anche in questa occasione corse il ricco parentume a salvargli “il culo”. Non ci sono lettere nella epistole che parlano chiaramente dell’accaduto, né nell’immediatezza del tragico evento né successivamente. Si evince invece che Burroughs non si dà affatto pensiero per la morte moglie ma si preoccupa unicamente di starsene un po’ nascosto per non dare nell’occhio prima di tirarsi fuori dai guai. Del resto lui era sempre un figlio di papà con laurea ad Harvard. Insomma, nessun segno di pentimento pervenuto dopo l’assassinio perché era tutto preso a scrivere per accontentare il suo editore a fini di lucro e a nascondersi, impiegando il suo tempo libero in sadici e sfrigolanti divertimenti: “Attualmente vivo in un orinatorio ristrutturato insieme a un ermafrodito e a una sequela di gatti. [...] Il mio passatempo preferito è torturare i gatti – ne arrivano sempre di nuovi. Soprattutto i siamesi. Quel pelo lungo e setoso urge un trattamento a base di cherosene e fiammiferi. Preferisco il cherosene alla benzina. Brucia più lento. Ti stupiresti a sentire i rumori che fa un gatto alla resa dei conti.” (p. 49). All’altezza di questa lettera Burroughs aveva ben 38 anni, non era quindi un ragazzino che faceva le sue prime crudeli esperienze di morte. Poi, a un certo punto, en passant, in una lettera del 13 luglio 1952, ancora da Città del Messico, indirizzata a Ginsberg e a proposito del confusionario stato di lavorazione di La scimmia sulla schiena, scrisse (p. 58): “Ho messo qualche riferimento a mia moglie qua e là. Non sparisce. Non è rilevante per la storia e quindi viene menzionata solo en passant e di tanto in tanto.” Con la stessa superficialità e mancanza di empatia e con vena giustificazionista, tornò a scriverne più avanti, sempre a Ginsberg, in una lettera del 1955 (pp. 117-118). Invero sono più gli altri a ricordare Joan Vollmer che il marito, come fa lo stesso Ginsberg nel componimento onirico A Dream Record: June 8, 1955. L’attenzione compassionevole di Burroughs era invero tutta rivolta ai tanti ragazzi, molto spesso minorenni, con i quali intesseva relazioni: “Il povero Kiki è stato ammazzato la settimana scorsa a Madrid da quella merda di un cantante cubano.” (p. 161), oltre che essere attento alla stesura dei suoi testi via via sempre più intossicati da dipendenze e perversioni. Eppure il curatore dell’edizione italiana, Ottavio Fatica, già dalla bandella garantisce che in questo libro si trova, anche, “Il racconto [...] perfino dell’uccisione accidentale della moglie” avendo curato, con tutta evidenza, “Le lettere di questo stupefacente epistolario” senza darsi il disturbo di leggerle, ma l’editoria italiana tradizionale è oramai ridotta a barzelletta, e tale grossolanità (o grassolanità?) non mi stupisce affatto – molto importanti sono invece le note, purtroppo poste non in calce alle lettere ma in una sezione dedicata a fine libro, prese e tradotte da Andrew Tanzi direttamente dalle due epistole originali riunite in questa pubblicazione, The Letters of William S. Burroughs 1945 to 1959 (1993) e Rub Out The Words. The Letters of William S. Burroughs 1959 to 1974 (2012), per la cura, rispettivamente, di Oliver Harris e Bill Morgan. Fatica che firma la postfazione, Postfazione Atrofizzata (pp. 331-354), in chiave mitomitica filosofeggiante sulla “parola” paranoide di Burroughs che a leggerla davvero ci sarebbe da sospettare che non abbia letto le lettere o che, peggio, non ne abbia compreso il loro concreto, vero peso specifico o che, peggio ancora, ne abbia artatamente omesso il reale gravoso contenuto, naturalmente biografico, lasciandosi prendere la mano dalla mitomania vuoto celebrativa che caratterizza classicamente la critica italiana a pagamento o senza senso.
Burroughs, a suo modo (cioè da misogino: “Di certo le donne hanno succhi velenosi, lo dico sempre.” p. 89, che non sopportava neanche l’omosessuale effeminato, che non tardava a definire: “ricchione di merda”, p. 90), vale a dire accettando cinicamente e anaffettivamente la schermatura sociale che gli offrivano moglie e figlio, aveva rispetto di sua moglie ma non l’amava (quando invece emergono grandi in questa epistole l’amore e la stima per Kerouac e Ginsberg, quest’ultimo anche suo fidatissimo agente letterario e di cui era ossessivamente innamorato: “Ma lo amo e niente può cancellare l’amore.” p. 87: Burroughs, satiriaco e tossico dipendente, per i poeti della Beat Generation, sia chiaro, è stato come un fratello maggiore che li ha iniziati alle pratiche omosessuali e alle droghe insieme, ma non ha avuto su di loro alcuna influenza letteraria, difatti nell’opera differiscono grandemente pur procedendo parallelamente; a Burroughs interessava davvero solo il sesso e le droghe, e ogni sua azione mirava a questi due soddisfacimenti) e non voleva sicuramente ucciderla, anche se erano lì lì per separarsi – che non vuol dire mai spararsi. Il loro era un matrimonio di fatto perché mai celebrato; ma questa unione non era di alcun impedimento alle proprie inclinazioni omoerotiche: lui era un omosessuale, ed era ben cosciente di esserlo ma per nulla pacificato perché una aperta accettazione della propria sessualità restava inconfessabile verso i suoi famigliari in quanto avrebbe rischiato di compromettere anche il sostegno economico che gli offrivano ritrovandosi in un attimo povero e imprigionato dalla tossicodipendenza – addirittura, a trentotto anni suonati, in una lettera indirizzata a Ginsberg del 15 maggio 1952 chiedeva aiuto per escogitare uno pseudonimo letterario che non lo rendesse riconoscibile ai parenti: “Ti viene in mente un bel nome per me? Lee va bene come cognome ma Bill Lee è un po’ troppo riconoscibile. Penso ai miei Vecchi, mi capisci.” (p. 54). Tornando alla lettera a Ginsberg del 1° maggio 1950, scriveva a proposito (p. 33-34): “Nutro parecchi dubbi su un eventuale programma per superare la condizione di frocio attraverso ‘un impegno diligente, ad esempio studiare per imparare un mestiere’. Troverai, credo, che non è così semplice. Il fatto è che al momento nessuno capisce questa condizione, anche se, ovviamente, gli psichiatri dichiarano di capire tutto.” (p. 34). Qui faceva ferimento ai trattamenti psichiatrici ai quali Ginsberg si sottopose pensando di guarire la sua omosessualità affinché fosse ammesso alla Columbia University (Burroughs aveva già affermati a proposito la sua contrarietà e scetticismo in una precedente lettera indirizzata a Kerouac, p. 25, dove feroce affermava: “Mi sembra che non ci sia nulla da cavare da questa faccenda del Centro Medico, una massa di freudiani del New Deal.”). In una lettera di un anno più tardi, indirizzata sempre a Ginsberg, scriveva (p. 36): “Si parla di sesso, e questo è l’argomento più difficile di cui scrivere.” In quel periodo stava lavorando a Junkie, 1953. E più avanti torna sulla questione omosessuale (p. 38-39): “A proposito, abbiamo un conto in sospeso che mi fa star male da molto tempo. In una di quelle lettere quadrate che mi hai scritto dicevi: ‘Tu in realtà non vuoi che io superi questa condizione di frocio. [...]’ Se anche avessi un interesse sessuale nei confronti di qualcuno sarei comunque felice di vederlo passare alle donne se ne fosse capace e non si stesse solo prendendo in giro da solo. [...] Il mio orientamento sessuale mi è chiaro tanto quanto lo sono gli oggetti concreti. Non me ne vado da nessuna parte, non potrei e non voglio. Non dubito che sia possibile cambiare da frocio a eterosessuale.” Insomma, checché ne pensasse l’offuscato Burroughs, è certo che Sigmund Freud sul complesso intreccio tra sessualità e personalità ne aveva intesi i particolari riflessi sociali prima e meglio di chiunque altro: la negazione della propria sessualità, la rinuncia a una sua piena manifestazione sentimentale, rovina l’uomo e, di conseguenza, l’intera società: “Sento che sono sempre più vicino alla risposta alla mia condizione di frocio e comporterebbe una soluzione a quella malattia. Perché è proprio un’orribile malattia. Almeno per me. Ho appena vissuto l’emergere del mio lato non frocio come personalità separata. [...] Immaginati di aver tenuto un ragazzo non frocio in una camicia di forza di carne per venticinque anni e averlo costretto tutto il tempo ad agire e parlare da frocio. Ti vorrebbe bene? Non credo.” (pp. 162-163) e in una lettera successiva: “Sono arrivato al punto in cui non voglio più vedere alcun ragazzo, non ce la faccio. Mi serve un po’ di fregna. Non avrei mai dovuto essere frocio.” (p. 168). E siamo nel 1957, quattro anni più tardi dalla predica omosessualista fatta a Ginsberg.
Ma di tutte le lettere, per la maggior parte indirizzate ad Allen Ginsberg – alcune molto lunghe al quale, appunto, contestava la sua inclinazione al socialismo e al comunismo, allo “Stato Assistenziale”diceva Burroughs: “Temo che stiano andando verso il socialismo, il che significa, ovviamente, sempre più interferenze negli affari di ogni singolo cittadino.” scriveva a proposito della sorte degli Stati Uniti d’America in una lettera a Kerouac speditagli da Città del Messico il 1° gennaio 1950 (p. 28) –, la più importante da un punto di vista letterario, quella che dà Vero valore all’intera pubblicazione, è l’epistola datata 30 gennaio 1949, la sesta della raccolta e spedita a Ginsberg da Algiers, un quartiere di New Orleans, dove scriveva (p. 17): “Non posso esimermi dal commentare il rispettivo atteggiamento dei diversi individui coinvolti nel giro, un viaggio che a livello di mera e compulsiva inutilità regge bene il paragone con le migrazioni di massa dei maya. Attraversare il continente per portare Jack a Frisco dove intende restare tre giorni prima di ripartire per New York... Ovviamente lo ‘scopo’ del viaggio è stato scelto con cura per simbolizzarne l’inutilità di fondo. Di certo è Neal l’anima di questo viaggio dentro il moto più puro, astratto e insignificante.” Burroughs, senza saperlo, e in quel momento non poteva saperlo nessuno, neanche il suo autore, stava scrivendo a Ginsberg di On the Road, l’unico libro che ha davvero cambiato il mondo perché ha insegnato che esiste un viaggio che non sia solo emigrazione, che non sia solo spinto da ragioni economiche o politiche: On the Road ha insegnato che il viaggio non è a esclusivo appannaggio dei più abbienti dediti a bovarismo ma primaria necessità di conoscenza dell’uomo.
Neanche una parola è spesa nell’epistolario a proposito della morte di Kerouac (21 ottobre 1969). Del resto il distacco dai Beat da parte di Kerouac avvenne appena dopo la pubblicazione di On the Road (1957), e ciò successe soprattutto per via della deriva politica attivista e sinistroide che stava prendendo il movimento sotto la spinta di Ginsberg (a tal proposito, per rilevare lo stato d’animo del gruppo, è utile la lettura della lettera che Burroughs inviò da Parigi a quest’ultimo datata 24 luglio 1958, pp 170-173: neanche sulla morte di Neal Cassady, 4 febbraio 1968, si spende una sola parola in questo epistolario).
I principali corrispondenti di questa epistole moriranno entrambi nel 1997, Ginsberg a settant’anni, in aprile, e Burroughs a ottantatre, in agosto. Ma Burroughs, fino alla fine dei suoi giorni (ricordiamo che lui è del ‘14, quindi è il più vecchio del gruppo), ha sempre riconosciuto la grandezza di Kerouac e come fosse stato lui l’inventore di tutto quello che si riferisce alla Beat Generation, movimento che vedeva Burroughs a latere, cioè conduceva una ricerca tutta sua soprattutto concentrata sulla sperimentazione delle droghe, arrivando addirittura alla presunzione di proporre anche delle tecniche e terapie pseudoscientifiche per la cura della tossicodipendenza, il tutto allo scopo di autogiustificare le proprie perversioni e dipendenze, fino a indicare, di volta in volta e in base agli effetti che empiricamente osservava su di sé, quali droghe usare e quali invece evitare assolutamente.
Gli epistolari hanno tutti il medesimo difetto: mancando della lettera di riscontro, appaiono spesso dei soliloqui incomprensibili. E ciò vale anche per questa pubblicazione, che consuma tutta la sua forza propulsiva nelle prime 70-80 pagine al massimo. Nelle 141 lettere scritte con discontinuità tra il 1946 e il 1973 (solo 12 sono indirizzate a Kerouac, ma restano le più interessanti per la completa conoscenza del reale pensiero dell’autore perché da quella parte trovava un interlocutore più vicino alle sue idee politiche, essendo Kerouac un conservatore cattolico: i maggiori interlocutori sono Ginsberg, con 63 lettere spedite prevalentemente da Tangeri dove Burroughs ha mantenuto stabile dimora dal 1954 al 1958, e Brion Gysin, con 25 lettere, mentre gli altri ricevono giusto una lettera o qualcuna in più, appena 3 la madre, Laura Lee Burroughs 1888-1970, e 6 il figlio, William S. Burroughs Jr 1947-1981, di cui si dovevano occupare gli altri perché il padre doveva invece preoccuparsi di come fare a sfuggire alle autorità statunitensi che lo ricercavano, pp. 236-237, che dal padre erediterà soprattutto le dipendenze fino a morirne a soli 33 anni; ma il cuore di tutta l’epistole è Ginsberg, che tre lettere condivide con Kerouac, con il quale però si interrompe definitivamente la corrispondenza il 26 ottobre 1961, p. 203, a favore di Gysin, nuova fissazione omoerotica di Burroughs, e queste sono sicuramente le lettere meno interessanti tra quelle raccolte che si possono pure tralasciare – poi c’è una farneticante drogata allucinata lettera indirizzata a Truman Capote che a riceverla ci sarebbe da avere paura, pp. 283-285, se non ci fosse solo di che riderne), Burroughs, senza saperlo e senza falsità e ben lontano nel tempo e nello spazio dal falso e imperante buonismo attuale, esprimeva, liberamente perché senza mire editoriali, i sentimenti di una persona malvagia.
“Il missionario è giunto alla conclusione che sono l’Anticristo e non avrà più niente a che fare con me.” (p. 78).
È inutile scrivere nel tentativo di giustificare la propria esistenza: la vita è un dono, e i doni vanno accolti sempre con gratitudine e silenzio, per non arrecare inutile danno.
MASSIMO RIDOLFI