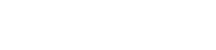POESIA: RUE DES ÉTRANGERS
– a Natura, alla sua attenta lettura
«buona una pioggia fine senza tregua a metà della vita»
Raymond André
A un libro di poesia ci si avvicina con il corpo.
Il corpo innanzitutto. Perché la parola è corpo. Tangibile come un corpo è la parola. Che come il corpo canta, emette suoni per dare corpo ai segni in cerca di un senso. Il corpo è un sacro strumento. È il primo strumento umano.
Antonio Alleva, fraterno amico e curatore (unitamente a Patrizia Vernisi, fedele compagna di vita e custode dell’opera del poeta di Bernissart), apre la sua ultima fatica letteraria (Cronache di fine Occidente e La Collina del Dingh, Puntoacapo, 2023) proprio con una poesia di Raymond André (1956-2010), Un buon custode (p. 48), aggiungendovi questa epigrafe: «Come vedi, caro Henrì, il buon custode persevera / e tiene alta la fiamma.» a suggello di una inesauribile alleanza a tredici anni dalla scomparsa dell’amico e del poeta.
Rue des étrangers, portato alle stampe nel 2014 dalla più raffinata e attenta casa editrice di poesia italiana, Il Ponte del Sale, è il terzo e ultimo canto di Raymond André – prima ci sono Segnali d’ombra (Andromeda 1999) e Le vetrate di Saint Denis (Manni 2004), quindi ci troviamo innanzi a una pubblicazione postuma che raccoglie con scienza e coscienza le ultime carte del poeta, vale a dire che con rigore filologico si è portato in salvo questi scritti. È un libro di raccolta, dove troviamo persino la riproduzione per immagini dei suoi ultimi rari segni. Autografi (Pioggia sulla tenda, con varianti poste a mano dall’autore, tentando una «inconsapevole perfezione», p. 30; e versione definitiva a p. 34, che diventa Acqua e sale). Fotografie (troviamo uno scatto rubato che ci mostra il poeta stesso, p. 6). Cartoline, come quella della cripta dell’Eremo di S. Croce di Fonte Avellana nella Marca inviata all’amico Antonio, dove lo informava che occupava la cella che fu di S. Romualdo tra lodi e vespri lectio e silenzi (p. 15) – teniamo per il momento da parte questo dato: ci torneremo in seguito, ci sarà utile per la lettura di questo libro.
Ecco, il libro: questo volume ci testimonia la presenza ancora viva di un uomo che non si sente mai solo, che, però, sceglie i suoi interlocutori con parsimonia; che sceglie Maurice come destinatario privilegiato delle sue lettere, che chiama – i nomi li sceglie chi chiama – già alla prima poesia in silloge, eponima, quindi intitolando l’intero lavoro, Rue des étrangers (p. 19), dove si slancia «per l’incontro con qualche verità umana» – presupposto coraggioso perché rischioso ad ogni buon conto di verità. Maurice è il compagno della sua formazione belga accanto alla miniera, in attesa dei padri, la risalita di «quei visi innevati di carbone» (Le donne, les enfants, les anges mineurs, p. 45): «(i nostri padri ci accompagnano sul portapacchi della bicicletta / verso la scuola, poi la campanella all’unisono / con la sirena per noi l’entrata per loro la discesa» (La strada verso Liegi, 46).
Ecco allora l’abbrivio, la spinta all’altro che è sempre contenuta nell’anima dura di ogni buona poesia, vale a dire quel peso che sa metterci il poeta autentico perché non la tenti alla leggerezza dell’etere bensì la ancori a terra – mentre l’autore, il prestatore d’opera, resta dietro la siepe a spiare il cielo, instancabile.
E così ci troviamo dentro un libro tutto esperienziale. E dalla materia indispensabile dell’esperienza, si eleva nel verso detto (il verso è sempre detto prima ancora che essere scritto) per sublimazione, cioè quella speciale alchimia che alcuni uomini sono capaci di combinare per giungere al manufatto d’arte, vale a dire a quell’oggetto (ogni poesia va intesa come plastica esposizione lirica) capace di sintesi universale dell’esperienza – per universale va inteso di cosa riconducibile all’uomo, e da questo riconoscibile come «latte di madre» (Sono vissuto o ho vissuto, p. 28).
Ma non pochi sono i fogli misteriosi di questa silloge, fatta di significanti interlinee e spaziature, o che concede a volte solo linee tratteggiate come a portarci dentro la spirale di un gioco enigmistico (ancora Rue des étrangers, p. 19, per esempio), segni di una precisa partitura ritmica lasciati in pentagramma, come armonia e melodia fermate sul rigo musicale: «solo uno spazio per l’addestramento alla lettura dello spartito vuoto» (La a stanza di Maurice, p 36).
Ma torniamo ora a quella Cartolina (p. 15), quella della cripta dell’Eremo di S. Croce di Fonte Avellana nella Marca inviata all’amico Antonio, e dentro la cella che fu di S. Romualdo dove soggiornò il poeta, tra lodi e vespri lectio e silenzi – «mi alzai presto quel mattino fuori c’era freddo / non era crudele né fiero non richiamava l’onnipresenza / dell’ombra della falce» (Lectio, p 44): l’uomo tende sempre all’alto; è sempre il cielo che guarda in cerca di risposte, combattendo quel peso che lo ancora a terra, dietro la siepe a spiare il cielo, instancabile; come la poesia tende all’alto, perché non è altro che una preghiera laica e balbettante, e senza bandiere, fatta dentro fogli misteriosi, a incrociare il silenzio del foglio bianco in cerca di sé, recitando «la preghiera pregata del nulla da aggiungere / ai residui fossili di grandi esplosioni» (Tavoletta di creta, p. 37).
Fare poesia – «giovani spoglie riconciliate dove abita l’io scomparso» (Biglietto di ritorno, p. 35) –, scopriamo allora con Raymond André, è la più intensa attività di ricerca dell’uomo e del suo corpo nella quale ci si possa avventurare (lacerto lacerto; esperienza esperienza; esperimento esperimento), attività capace di non curare neanche un raffreddore ma che lo stesso guarisce tutta l’umanità, anche quella parte che non si volta, che non pratichi il sentire.
MASSIMO RIDOLFI